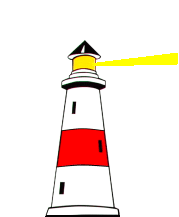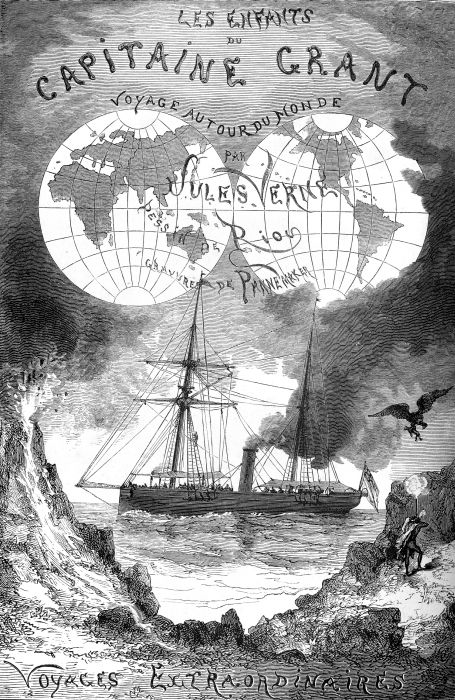Vediamo. Da dove comincio a scrivere questa recensione tanto difficile? Facciamo così, partiamo dai fatti e poi passiamo alle impressioni.
Si tratta di un romanzo di avventura pubblicato nel 1867 dal mostro sacro della scrittura francese Jules Verne - che come sapete io amo moltissimo - e costituisce il primo capitolo di una trilogia che prosegue con Ventimila leghe sotto i mari e si conclude con L'isola misteriosa. È diviso in tre parti: la prima ambientata in Patagonia, la seconda in Australia e la terza in Nuova Zelanda.
Il romanzo fu pubblicato dapprima a puntate sulla rivista letteraria francese Magasin d'Éducation et de Récréation; poi in un volume triplo.
INCIPIT SENZA SPOILER
Nel luglio 1864, durante una gita di Lord e Lady Glenarvan a bordo del loro yacht Duncan, viene catturato al largo di Glasgow uno squalo nel cui stomaco è rinvenuta una bottiglia con all'interno alcuni fogli scritti. Dall'esame delle poche parole leggibili si comprende che la bottiglia era utilizzata dal capitano scozzese Grant, comandante della nave Britannia, per veicolare una richiesta di aiuto dopo il naufragio della nave. Nel messaggio è indicata la latitudine (37° 11') del luogo in cui è naufragato il Britannia, ma l'indicazione della longitudine è stata cancellata dall'acqua di mare penetrata nella bottiglia.
Lord Glenarvan decide di partire alla ricerca del capitano Grant col suo yacht Duncan, guidato dal giovane comandante John Mangles. Fanno parte della spedizione lady Helena Glenarvan, il maggiore Mac Nabbs e i due figli del capitano Grant: la sedicenne Mary e il dodicenne Robert. Si unirà a costoro il cartografo francese Jaques Paganel, imbarcatosi distrattamente sul Duncan anziché su una nave diretta in India.
— Mi pare di vederlo ancora! — soggiunse il fanciullo come se parlasse a se stesso. — Quand'ero piccino, mi faceva addormentare sulle sue ginocchia, e mormorava sempre un vecchio ritornello scozzese che canta i laghi delle nostre terre. Mi torna talvolta in mente il motivo, ma confusamente, e anche a Mary accade lo stesso. Ah, milord, come lo amavamo! Ecco, io credo che bisogna essere piccoli per amar il proprio babbo!
— E grandi per venerarlo, figlio mio — rispose Glenarvan, commosso dalle parole sfuggite a quel giovane cuore.
COSA NE PENSO
Dunque. La prima cosa che ho pensato quando ho iniziato il libro - se vi ricordate molti mesi fa - è stato: "Wow, parte in quarta, mi piace molto! Come ogni libro letto fino ad ora di Jules Verne!"
Nel caso vi siate persi le mie altre recensioni, ecco qua Ventimila leghe sotto i mari, L'Isola Misteriosa, Il giro del mondo in 80 giorni, Viaggio al centro della Terra e Michele Strogoff.
Come dicevo, mi è piaciuto lo stile narrativo di Verne, molto romantico e delicato, sempre ricercatissimo, ma nonostante questo piuttosto scorrevole.
La prima cosa che ho pensato, invece, quando ho letto l'ultima pagina, è stata: "Grazie Signore!!! E' finito!!!" E un senso di spossatezza, di enorme fatica, mi è calato addosso schiacciandomi sul divano.
Sì, si tratta di un libro davvero faticoso. Come posso spiegarmi meglio? Ecco, userò alcune parole tratte dal Blog "La Casa di Roberto", scovato per caso in rete qualche giorno fa.
"Non so se alla fine io sia più allibito per la protervia con cui Verne ha cucito insieme, con un pretesto esile, almeno tre romanzi diversi, o ammirato dal consumato mestiere con cui lo ha fatto.
Les enfantas du capitaine Grant è un catalogo seriale di avventure varie, prolungate, allungate, ripetute, legate fra loro come le novelle del Decamerone da un pretesto narrativo esile che fa da cornice (il viaggio per ritrovare il Capitano) con un cast di personaggi ricorrenti il cui carattere è fissato inizalmente una volta per tutte e ai quali non è concessa, peraltro, alcuna forma di crescita."
Ecco fatto. In pochissime righe, Roberto ha espresso perfettamente il mio pensiero. I figli del capitano Grant è esattamente questo: il libro parte in quarta, poi prosegue in modo metodico, cadenzato, percorrendo miglia e miglia fino ad arrivare in Patagonia, luogo dove accadono svariati episodi che più o meno hanno a che fare con la trama principale, ovvero la ricerca del Capitano Grant che, come avrete capito, si rivelerà infruttuosa.
Intorno alle 200 pagine, i nostri eroi capiscono che il percorso fatto fino a lì è stato vano e così, tornando a interpretare nuovamente il biglietto ritrovato nella bottiglia, s'imbarcano per una nuova avventura in direzione Australia. Come nel caso precedente, il libro prosegue il viaggio di miglia e miglia (a piedi e in carovana) per altre 200 pagine, dove si susseguono svariati avvenimenti che non sempre hanno uno stretto legame con la trama principale.
Il ciclo a questo punto ricomincia e tu, lettore, sei già molto provato da questo viaggio interminabile fra foreste, distese sterminate, laghi, fiumi, città, montagne e molto, molto altro. Intorno a pagina 400 (il libro è di 600 pagine circa), di nuovo, i nostro eroi cambiano meta, dirigendosi verso la pericolosa Nuova Zelanda. E' a questo punto che il lettore inizia a pregare che il benedetto Capitano Grant faccia finalmente capolino fra le pagine del libro.
Le descrizioni dei luoghi, dei paesaggi, della flora e della fauna, sono poco "narrate" e sembrano piuttosto stralci tratti da libri di geografia politica o scienze naturali. Persino in punti caldi della trama, Verne si ferma d'un tratto per spiegare con fare accademico la storia dell'Australia, il periodo fertile della febbre dell'oro, l'economia del paese o la classificazione della fauna utilizzando persino i nomi tassonomici degli animali o delle piante, per non parlare dei dati statistici e delle date di avvenimenti storici salienti. Istruttivo, per carità, ma il romanzo ne perde in bellezza, in profondità e in poesia. In modo cadenzato, sembra quasi di tornare a scuola e di star leggendo un passo dal vecchio libro di geografia o di scienze.
In ogni libro di Verne - quanto meno in quelli letti fino ad ora- , vi è di solito un personaggio, in questo caso il geografo Paganel, esperto di un ramo della scienza utile allo svolgimento del romanzo.
In Ventimila leghe sotto i mari, c'era il Professor Aronnax, celebre naturalista del Museo di Storia Naturale di Parigi famoso per aver pubblicato un'opera sulla vita sottomarina (ma guarda un po'), nell'Isola Misteriosa c'erano Cyrus Smith, ingegnere e Harbert Brown, appassionato di scienze naturali, mentre in Viaggio al centro della Terra c'era Lidenbrock, professore rinomato di mineralogia.
Ho sempre pensato che questi personaggi "esperti", altro non fossero che l'alter ego dello stesso scrittore, appassionato infatti come loro, a una vasta gamma di materie scientifiche. Questo espediente permetteva a Verne di trasformare i suoi libri in testi quasi accademici, dove poteva sentirsi libero di coinvolgere il lettore nello studio di scienze naturalistiche, geologia, fisica, astronomia, ingegneria e navigazione. Personalmente, soprattutto ora, dopo la lettura di questo lungo romanzo, penso a Verne come a un moderno Alberto Angela, talmente appassionato di scienze e curioso su qualunque argomento, da voler diventare divulgatore attraverso i suoi libri.
Anzi, vi dirò: è quasi come se il romanzo stesso fosse l'espediente. Come se venisse in secondo piano rispetto all'amore per la divulgazione scientifica.
Come ho scritto nella mia recensione de L'isola misteriosa:
"Il libro, scritto in uno stile impeccabile, è colmo di descrizioni pratiche e scientifiche, specialmente su ciò che concerne la sopravvivenza, la costruzione di un campo base, la creazione di armi e l'approvvigionamento di viveri. E' il libro perfetto da portarsi sempre dietro quando si viaggia, perché nel caso di naufragio et similia, sarà molto più utile del Manuale delle Giovani Marmotte, ve lo posso assicurare. Dopo averlo letto, anche voi sarete in grado di sopravvivere mesi in un luogo sperduto."
Le descrizioni delle manovre effettuate dai marinai sul Duncan o su altre imbarcazioni, sono estremamente descrittive e puntigliose, con lunghi brani dove non si parla d'altro che di "cazzare la randa", alberi di "trinchetto", di come ripiegare il "terzaruolo", fissare la "scotta" o di come sistemare il "parrocchetto".
Capirete anche voi che senza una conoscenza almeno basilare delle nozioni di navigazione, un lettore possa rischiare di addormentarsi dopo il terzo "picco" o la quarta "ralinga".
Questo difetto, se così possiamo chiamarlo, è presente in tutti i libri di Verne, ma ne I figli del capitano Grant si accusa molto di più che in tutti gli altri suoi romanzi.
Va bene essere descrittivi, va bene anche l'intento istruttivo che un libro può e deve avere, ma eccedere in questo non fa altro che annoiare il lettore e far perdere mordente al leitmotive principale del romanzo.
Come sottolinea Roberto, il "cast" del romanzo è ben caratterizzato (meno le parti femminili, a dire il vero), ma dall'inizio del viaggio alla fine, durante tutti quei mesi di ricerca, nessuno di loro matura in modo vistoso, nemmeno Robert, che viene già presentato al lettore come un piccolo e coraggioso ometto.
Abbiamo usato la parola cast perché I figli del capitano Grant somiglia di più a una serie TV, che a un libro. Il format usato da Verne è quello di Lost - lo so, caso mai è il contrario, ma capitemi -. Si tratta di brevi avventure, brevi racconti che vanno a legarsi come una collana di perle dalla prima all'ultima pagina. Non c'è nemmeno un vero protagonista principale, ma tutti a loro modo portano avanti la storia, esattamente come Jack, Kate, Charlie, Sawyer, Hugo e gli altri protagonisti di Lost. Tutti importanti, nessuno indispensabile.
Tanto che se oggi, a qualche regista (leggi JJ Abrams), venisse in mente di fare un remake moderno di questo libro, beh, sono sicura che ne uscirebbe un capolavoro.
Un aspetto che mi ha colpita, (né in senso negativo, né positivo, ma solo colpita), è la totale assenza di elementi futuristici o "misteriosi". Elementi che in ogni altro libro di Verne (Michele Strogoff a parte) non mancano mai. Da colui che è considerato un po' il padre della moderna fantascienza, me lo sarei aspettato. Manca persino il piacere della scoperta. Mi spiego meglio: in una terra in parte semi inesplorata come la Patagonia, l'Australia o la Nuova Zelanda, in particolare a metà '800, mi sarei aspettata di finire con la mia carovana di protagonisti, in luoghi completamente vergini dalla presenza dell'uomo, foreste incontaminate e quasi magiche (nel pieno stile di Verne), ma questo non accade mai. La sensazione di viaggiare in luoghi che non hanno quasi nulla da scoprire permea tutto il romanzo. Anche l'incontro con qualche sperduta tribù isolata da sempre, sarebbe stata d'effetto.
Si tratta, alla fine, di un libro ben scritto (e sfido chiunque a dire il contrario), che vanta pagine che sono delle piccole perle, nascoste nel mare di prolisse descrizioni faunistiche e geografiche. A mente lucida, ora che l'ho terminato, posso dire che mi è piaciuto, ma durante la lettura, vi assicuro che ho avuto l'istinto in diversi momenti di scaraventarlo contro al muro :)
Andrei avanti ancora molto, in questa mia recensione, perché di cose da dire ce ne sarebbero davvero parecchie, ma mi fermo qua, perché toccare certi argomenti significherebbe fare spoiler. Oddio, ora che ci penso, non è che ci sia molto da spoilerare... :)
Concludo consigliando questo libro solo a chi vuole leggersi l'intera saga. Tutti gli altri possono serenamente saltarlo e passare direttamente al meraviglioso Ventimila leghe sotto i mari, terminando con il meno meraviglioso, ma comunque molto bello e leggero L'isola misteriosa.
Sarei curiosa di vedere una delle tre trasposizioni cinematografiche, ma ammetto che la cosa mi fa paura.
Vi lascio con una di quelle perle, di cui vi parlavo poco fa.
"L'insieme di quei terreni ha sulle carte inglesi un nome molto espressivo: “Reserve for the blacks”, la riserva per i neri. È là che gl'indigeni furono brutalmente respinti dai coloni, lasciando nelle loro lontane pianure, sotto boschi inaccessibili, alcuni spazi determinati, in cui la razza aborigena si estinguerà poco alla volta.
Ogni uomo bianco, colono, emigrante o squatter o bushman può superare il confine di quelle riserve, solo il negro non deve mai uscirne.
Paganel, mentre cavalcava, discuteva questa grave questione delle razze indigene e unanime fu il parere a questo proposito, cioè che il sistema britannico spingeva a distruggere le popolazioni conquistate e a cancellarle dalle regioni dove vivevano i loro antenati. Questa tendenza fu notata in ogni luogo, e in Australia più che altrove. Ai primi tempi della colonia, i deportati, i coloni stessi, consideravano i negri come animali selvaggi, li cacciavano e li uccidevano a schioppettate, li trucidavano, e s'invocava l'autorità dei giureconsulti per provare che l'uccisione di quei miserabili non rappresentava un delitto.
I giornali di Sidney proposero persino un mezzo efficace per sbarazzarsi delle tribù del lago Hunter: avvelenarli in massa. Come si vede, gli inglesi, agli inizi della loro conquista, chiamarono l'omicidio in aiuto alla colonizzazione. Le loro crudeltà furono atroci; si comportarono in Australia come nelle Indie, dove cinque milioni d'indiani scomparvero, come al Capo, dove la popolazione aborigena, decimata dai cattivi trattamenti e dall'ubriachezza, tende a scomparire dal continente di fronte a una civiltà omicida.
Gli omicidi si organizzarono su vasta scala e intere tribù scomparvero; per citare solo l'isola Van Diemen, questa al principio del secolo contava cinquemila indigeni e nel 1863 aveva sette abitanti.
— Cinquant'anni fa, — aggiunse Paganel, — avremmo incontrato molte tribù di indigeni, mentre finora non ne è comparso uno. Fra un secolo, questo continente sarà del tutto spopolato della sua razza nera."
Le descrizioni dei luoghi, dei paesaggi, della flora e della fauna, sono poco "narrate" e sembrano piuttosto stralci tratti da libri di geografia politica o scienze naturali. Persino in punti caldi della trama, Verne si ferma d'un tratto per spiegare con fare accademico la storia dell'Australia, il periodo fertile della febbre dell'oro, l'economia del paese o la classificazione della fauna utilizzando persino i nomi tassonomici degli animali o delle piante, per non parlare dei dati statistici e delle date di avvenimenti storici salienti. Istruttivo, per carità, ma il romanzo ne perde in bellezza, in profondità e in poesia. In modo cadenzato, sembra quasi di tornare a scuola e di star leggendo un passo dal vecchio libro di geografia o di scienze.
In ogni libro di Verne - quanto meno in quelli letti fino ad ora- , vi è di solito un personaggio, in questo caso il geografo Paganel, esperto di un ramo della scienza utile allo svolgimento del romanzo.
In Ventimila leghe sotto i mari, c'era il Professor Aronnax, celebre naturalista del Museo di Storia Naturale di Parigi famoso per aver pubblicato un'opera sulla vita sottomarina (ma guarda un po'), nell'Isola Misteriosa c'erano Cyrus Smith, ingegnere e Harbert Brown, appassionato di scienze naturali, mentre in Viaggio al centro della Terra c'era Lidenbrock, professore rinomato di mineralogia.
Ho sempre pensato che questi personaggi "esperti", altro non fossero che l'alter ego dello stesso scrittore, appassionato infatti come loro, a una vasta gamma di materie scientifiche. Questo espediente permetteva a Verne di trasformare i suoi libri in testi quasi accademici, dove poteva sentirsi libero di coinvolgere il lettore nello studio di scienze naturalistiche, geologia, fisica, astronomia, ingegneria e navigazione. Personalmente, soprattutto ora, dopo la lettura di questo lungo romanzo, penso a Verne come a un moderno Alberto Angela, talmente appassionato di scienze e curioso su qualunque argomento, da voler diventare divulgatore attraverso i suoi libri.
Anzi, vi dirò: è quasi come se il romanzo stesso fosse l'espediente. Come se venisse in secondo piano rispetto all'amore per la divulgazione scientifica.
Come ho scritto nella mia recensione de L'isola misteriosa:
"Il libro, scritto in uno stile impeccabile, è colmo di descrizioni pratiche e scientifiche, specialmente su ciò che concerne la sopravvivenza, la costruzione di un campo base, la creazione di armi e l'approvvigionamento di viveri. E' il libro perfetto da portarsi sempre dietro quando si viaggia, perché nel caso di naufragio et similia, sarà molto più utile del Manuale delle Giovani Marmotte, ve lo posso assicurare. Dopo averlo letto, anche voi sarete in grado di sopravvivere mesi in un luogo sperduto."
Le descrizioni delle manovre effettuate dai marinai sul Duncan o su altre imbarcazioni, sono estremamente descrittive e puntigliose, con lunghi brani dove non si parla d'altro che di "cazzare la randa", alberi di "trinchetto", di come ripiegare il "terzaruolo", fissare la "scotta" o di come sistemare il "parrocchetto".
Capirete anche voi che senza una conoscenza almeno basilare delle nozioni di navigazione, un lettore possa rischiare di addormentarsi dopo il terzo "picco" o la quarta "ralinga".
Questo difetto, se così possiamo chiamarlo, è presente in tutti i libri di Verne, ma ne I figli del capitano Grant si accusa molto di più che in tutti gli altri suoi romanzi.
Va bene essere descrittivi, va bene anche l'intento istruttivo che un libro può e deve avere, ma eccedere in questo non fa altro che annoiare il lettore e far perdere mordente al leitmotive principale del romanzo.
Come sottolinea Roberto, il "cast" del romanzo è ben caratterizzato (meno le parti femminili, a dire il vero), ma dall'inizio del viaggio alla fine, durante tutti quei mesi di ricerca, nessuno di loro matura in modo vistoso, nemmeno Robert, che viene già presentato al lettore come un piccolo e coraggioso ometto.
Abbiamo usato la parola cast perché I figli del capitano Grant somiglia di più a una serie TV, che a un libro. Il format usato da Verne è quello di Lost - lo so, caso mai è il contrario, ma capitemi -. Si tratta di brevi avventure, brevi racconti che vanno a legarsi come una collana di perle dalla prima all'ultima pagina. Non c'è nemmeno un vero protagonista principale, ma tutti a loro modo portano avanti la storia, esattamente come Jack, Kate, Charlie, Sawyer, Hugo e gli altri protagonisti di Lost. Tutti importanti, nessuno indispensabile.
Tanto che se oggi, a qualche regista (leggi JJ Abrams), venisse in mente di fare un remake moderno di questo libro, beh, sono sicura che ne uscirebbe un capolavoro.
Un aspetto che mi ha colpita, (né in senso negativo, né positivo, ma solo colpita), è la totale assenza di elementi futuristici o "misteriosi". Elementi che in ogni altro libro di Verne (Michele Strogoff a parte) non mancano mai. Da colui che è considerato un po' il padre della moderna fantascienza, me lo sarei aspettato. Manca persino il piacere della scoperta. Mi spiego meglio: in una terra in parte semi inesplorata come la Patagonia, l'Australia o la Nuova Zelanda, in particolare a metà '800, mi sarei aspettata di finire con la mia carovana di protagonisti, in luoghi completamente vergini dalla presenza dell'uomo, foreste incontaminate e quasi magiche (nel pieno stile di Verne), ma questo non accade mai. La sensazione di viaggiare in luoghi che non hanno quasi nulla da scoprire permea tutto il romanzo. Anche l'incontro con qualche sperduta tribù isolata da sempre, sarebbe stata d'effetto.
Si tratta, alla fine, di un libro ben scritto (e sfido chiunque a dire il contrario), che vanta pagine che sono delle piccole perle, nascoste nel mare di prolisse descrizioni faunistiche e geografiche. A mente lucida, ora che l'ho terminato, posso dire che mi è piaciuto, ma durante la lettura, vi assicuro che ho avuto l'istinto in diversi momenti di scaraventarlo contro al muro :)
Andrei avanti ancora molto, in questa mia recensione, perché di cose da dire ce ne sarebbero davvero parecchie, ma mi fermo qua, perché toccare certi argomenti significherebbe fare spoiler. Oddio, ora che ci penso, non è che ci sia molto da spoilerare... :)
Concludo consigliando questo libro solo a chi vuole leggersi l'intera saga. Tutti gli altri possono serenamente saltarlo e passare direttamente al meraviglioso Ventimila leghe sotto i mari, terminando con il meno meraviglioso, ma comunque molto bello e leggero L'isola misteriosa.
Sarei curiosa di vedere una delle tre trasposizioni cinematografiche, ma ammetto che la cosa mi fa paura.
Vi lascio con una di quelle perle, di cui vi parlavo poco fa.
"L'insieme di quei terreni ha sulle carte inglesi un nome molto espressivo: “Reserve for the blacks”, la riserva per i neri. È là che gl'indigeni furono brutalmente respinti dai coloni, lasciando nelle loro lontane pianure, sotto boschi inaccessibili, alcuni spazi determinati, in cui la razza aborigena si estinguerà poco alla volta.
Ogni uomo bianco, colono, emigrante o squatter o bushman può superare il confine di quelle riserve, solo il negro non deve mai uscirne.
Paganel, mentre cavalcava, discuteva questa grave questione delle razze indigene e unanime fu il parere a questo proposito, cioè che il sistema britannico spingeva a distruggere le popolazioni conquistate e a cancellarle dalle regioni dove vivevano i loro antenati. Questa tendenza fu notata in ogni luogo, e in Australia più che altrove. Ai primi tempi della colonia, i deportati, i coloni stessi, consideravano i negri come animali selvaggi, li cacciavano e li uccidevano a schioppettate, li trucidavano, e s'invocava l'autorità dei giureconsulti per provare che l'uccisione di quei miserabili non rappresentava un delitto.
I giornali di Sidney proposero persino un mezzo efficace per sbarazzarsi delle tribù del lago Hunter: avvelenarli in massa. Come si vede, gli inglesi, agli inizi della loro conquista, chiamarono l'omicidio in aiuto alla colonizzazione. Le loro crudeltà furono atroci; si comportarono in Australia come nelle Indie, dove cinque milioni d'indiani scomparvero, come al Capo, dove la popolazione aborigena, decimata dai cattivi trattamenti e dall'ubriachezza, tende a scomparire dal continente di fronte a una civiltà omicida.
Gli omicidi si organizzarono su vasta scala e intere tribù scomparvero; per citare solo l'isola Van Diemen, questa al principio del secolo contava cinquemila indigeni e nel 1863 aveva sette abitanti.
— Cinquant'anni fa, — aggiunse Paganel, — avremmo incontrato molte tribù di indigeni, mentre finora non ne è comparso uno. Fra un secolo, questo continente sarà del tutto spopolato della sua razza nera."